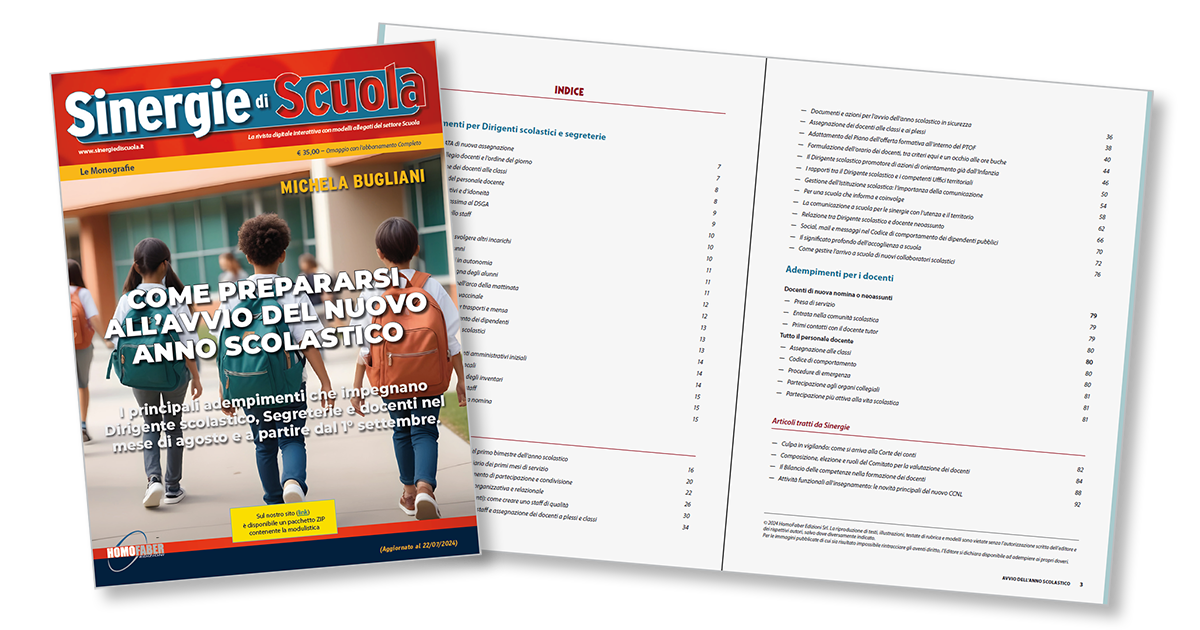Il tema delle incompatibilità nel pubblico impiego è costantemente oggetto di grande interesse da parte delle pubbliche amministrazioni, poiché disciplinato da normativa di dettaglio mutevole nel tempo, di variabile interpretazione e che, comunque, non esaurisce tutte le possibili casistiche che si possono verificare.
La sentenza di condanna della Corte dei conti della Lombardia n. 216 del novembre 2014 interviene sul tema delle incompatibilità infliggendo una condanna ad una dipendente che aveva svolto per lunghi periodi, senza essere debitamente autorizzata, un secondo lavoro.
La sentenza è pacificamente disposta in conformità delle disposizioni di legge, ma ha il pregio di riassumere la disciplina operante sul punto, e di individuare delle interessanti modalità operative per ciò che riguarda il calcolo delle somme da rifondere da parte dei dipendenti che si siano resi inottemperanti al divieto.
Specificità del pubblico impiego
La Corte, con la sentenza in questione, offre un interessante punto di vista sul pubblico impiego in un momento in cui riforme del lavoro “liberalizzatrici” e condotte mediatiche non certo di favore vorrebbero parificare del tutto l’impiego pubblico a quello privato, mentre il primo è soggetto a discipline peculiari che non sono affatto sempre “privilegiate”.
La magistratura contabile infatti, proprio a proposito dell’incompatibilità, interviene a questo proposito in maniera netta e chiara, con inciso che si riporta testualmente:
Il rapporto di lavoro con il datore pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico [...] è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative. La ratio di tale divieto, che permane anche in un sistema “depubblicizzato” a rimarcare la peculiarità dell’impiego presso la p.a., va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico (“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” art. 98 Cost.), per preservare le energie del lavoratore e per tutelare il buon andamento della p.a., che risulterebbe turbato dall’espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. Centri di interesse alternativi all’ufficio pubblico rivestito, implicanti un’attività caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l’indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della p.a. Un simile obbligo di esclusività non è rinvenibile nell’impiego privato, nel quale il codice civile si limita a vietare esclusivamente attività extralavorative del dipendente che si pongano in concorrenza con l’attività del datore (art. 2105 c.c.).
Una interpretazione cristallina di un divieto caratterizzante solo il pubblico impiego, divieto fortemente limitativo, peraltro, in un momento di perdurante e ultrannuale blocco contrattuale, che non consente neanche di arrotondare le entrate a differenza del settore privato.
Uno di quei tanti punti di differenza che dovrebbero essere rammentati da chi propugna una parificazione sic et simpliciter, e che dovrebbe essere certamente rivisto (e abolito) in caso di privatizzazione tout court.
Cenni sulle incompatibilità
La sentenza della Corte ripercorre la normativa vigente in materia di incompatibilità, primo fra tutti l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, disposizione cardine in materia, che richiama le ancora vigenti prescrizioni del d.P.R. 3/1957.
Tali disposizioni, si rammenta, prevedono:
- Attività del tutto vietate (attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, e altri lavori pubblici o privati);
- Attività consentite «ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (art. 53, co. 6, D.Lgs. 165 cit.)» che sono un numero chiuso, e corrispondono agli incarichi «derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica»;
- Attività consentite solo previa autorizzazione (di carattere occasionale e non professionale).
A proposito del regime autorizzatorio, che abbraccia gran parte dei casi, la Corte rammenta che l’autorizzazione stessa è finalizzata a verificare: ipotesi di conflitto di interessi, compatibilità dell’impegno con il proprio lavoro all’interno della struttura di appartenenza e con il rapporto di impiego, carattere saltuario e occasionale, alla luce anche della posizione rivestita dal dipendente.
Un ultimo punto, citato dalla Corte come elemento di valutazione in sede di autorizzazione, desta perplessità evidenti: per la magistratura contabile infatti l’autorizzazione è tesa a verificare, anche e in concreto, la «corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato». Non è chiaro cosa interessi istituzionalmente all’amministrazione se il dipendente altrove svolga incarichi non attinenti con la propria posizione, e quale sia il fondamento normativo di questa limitazione; ai fini della mancanza del conflitto di interessi, anzi, è elemento positivo lo svolgimento di attività totalmente inconferente con la propria.
Inoltre, a proposito del primo punto, ovvero della valutazione dell’insussistenza del conflitto di interessi, rammentiamo che la stessa ipotesi deve essere assente anche nel caso della attività consentite.
La sanzione pecuniaria: come calcolarla?
Le conseguenze a carico del lavoratore che disattenda le norme sulle incompatibilità sono gravose, e non solo di tipo disciplinare, ma anche pecuniario.
Come dispone l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, comma 7, infatti, «il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti». Il nuovo comma 7-bis, introdotto dalla Legge 190/2012 c.d. “anticorruzione”, aggiunge poi che «L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti».
Il caso di specie, premette la Corte, sarebbe un classico esempio di illecito amministrativo, ipotesi che riguarda offese minori di beni (anche costituzionali). «Nel rispetto del principio “ne bis in idem”» prosegue la Corte dei Conti «uno Stato ben può imporre una doppia sanzione (fiscale e penale, amministrativa e penale, amministrativa e disciplinare) per gli stessi fatti purché le misure punitive abbiano diversa natura e diversi fini. Nello stesso pubblico impiego sono assai frequenti, ed anzi crescenti (v. D.Lgs. 165 del 2001; D.Lgs. 150 del 2009; L. n. 190 del 2012) le previsioni normative che valorizzano la pluri-illiceità di talune condotte di pubblici dipendenti, che ben possono tradursi, per il medesimo fatto, in illecito penale, disciplinare, civile, amministrativo contabile e, persino, in responsabilità dirigenziale ex art. 21, D.Lgs. 165. Tali reazioni ordinamentali sono ben cumulabili tra loro e non sono certo alternative».
Ciò che invece rileva come estremamente interessante nella ricostruzione è il procedimento per la quantificazione del danno, che riduce, e di molto, le pretese della Procura, richieste per importo pari a quanto introitato dalla lavoratrice in virtù del suo lavoro esterno (€ 56.856,00 lordi). Conformemente a vasta giurisprudenza infatti, la Corte ritiene che per la quantificazione dell’importo si debba tener conto anzitutto della prescrizione per i fatti più risalenti nel tempo (prescrizione quinquennale), e poi della tassazione, per cui «la somma da recuperare è quella al netto delle imposte già corrisposte dalla convenuta a titolo di ritenuta d’acconto, ovvero l’importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente [...] Pertanto, all’importo lordo di Euro 56.856 reclamato dalla Procura, va detratta la ritenuta d’acconto del venti per cento operata dall’erogatore».
La Corte poi, alla luce della condotta leale della dipendente, delle generale conoscenza della sua attività da parte dei superiori, opera una ulteriore riduzione equitativa dell’importo, che risulta ammontante alla fine ad una cifra di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto.
La modalità di calcolo così operata costituisce una indicazione importante per le amministrazioni, che nel corso di eventuali recuperi non dovrebbero tener conto esclusivamente di quanto percepito ma operare attenta rivalutazione della cifra.