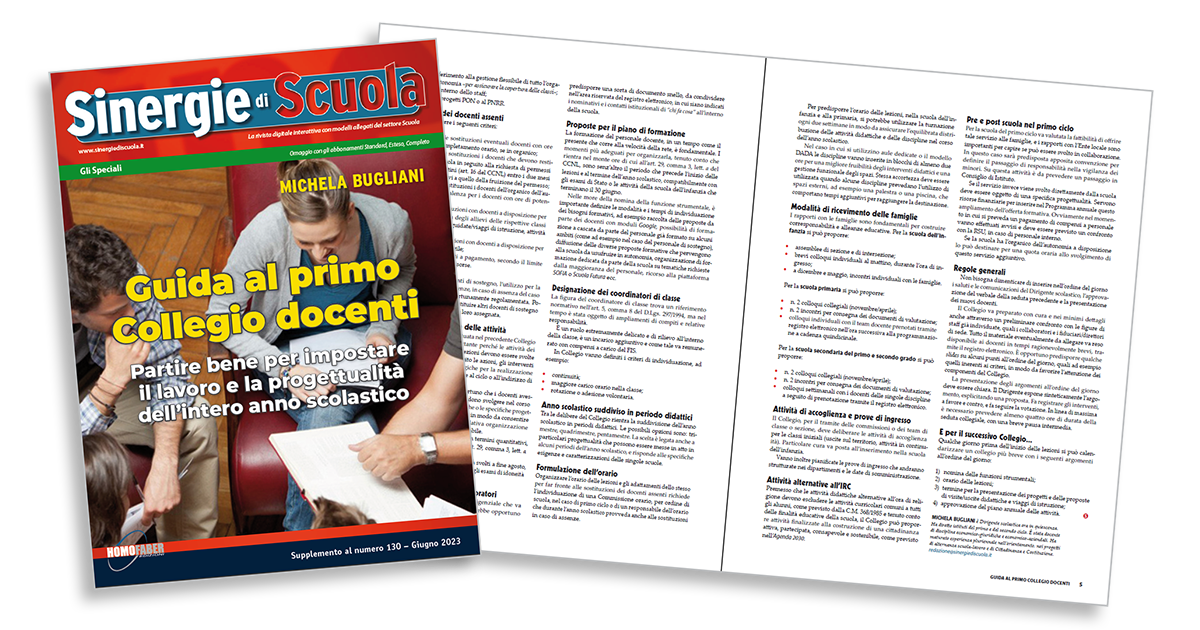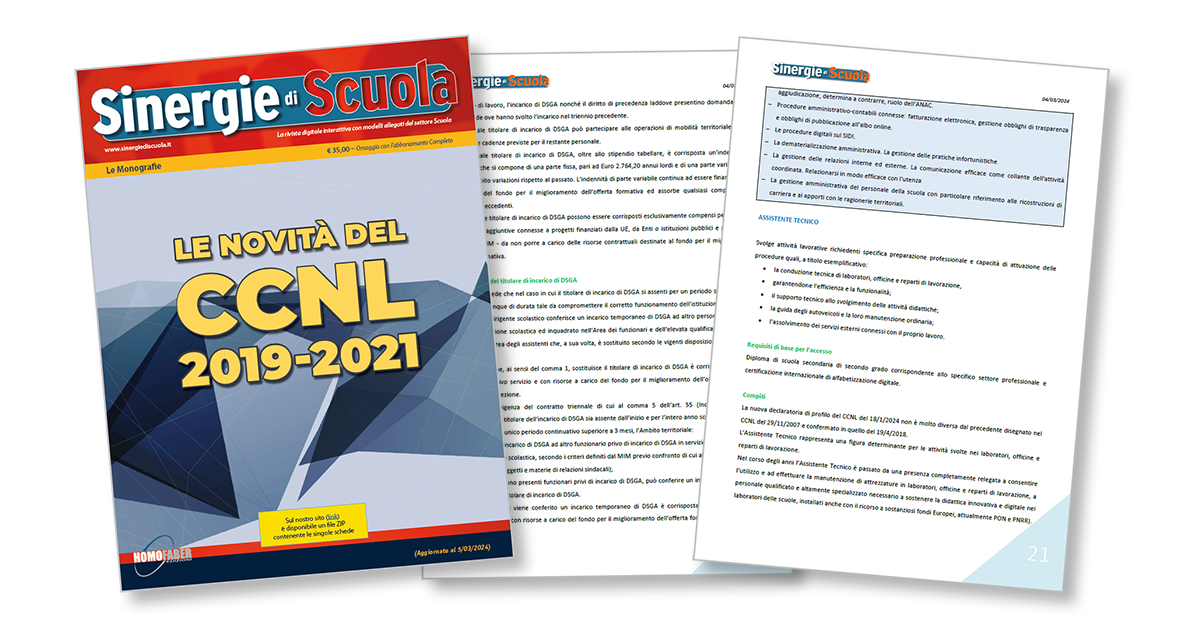Con il presente contributo si esaminerà la disciplina dettata dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 in materia di “Riposi e permessi per i figli con handicap grave”, in particolare quelli previsti dal comma 5.
Spunti di riflessione sono offerti dalle ordinanze della Cassazione, sezione Lavoro, n. 24206/2020 del 2/11/2020 e n. 26605/2020 del 23/11/2020, che – pur se i fatti di causa sono antecedenti alla novella del D.Lgs. 119/2011 – rilevano per l’attualità dei temi trattati e, soprattutto, per la comprensione della ratio dell’istituto e la sua natura.
La ratio dei permessi
Nell’ordinanza n. 26605/2020, l’oggetto del contendere è rappresentato dal rivendicato diritto di una lavoratrice, vittoriosa in primo e secondo grado, a fruire del congedo di cui all’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 nel limite massimo di due anni per ciascuno dei propri figli affetti entrambi da handicap grave.
Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia alla Suprema Corte la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001, nel testo vigente ratione temporis, art. 4, comma 2 della Legge 53/2000 e art. 2, comma 2 del D.M. 21/07/2000 n. 278; ad avviso dell’INPS non è possibile fruire più di una volta del congedo biennale nell’arco della vita lavorativa come specificato dal D.M. 278/2000 e dall’art. 4, comma 2 cit. che parla espressamente di «un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni».
Per la Suprema Corte il motivo è infondato, in continuità con il precedente specifico rappresentato dalla sua stessa sentenza n. 11031/2017: «Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall’avente diritto, anche nell’ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno; talché esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell’arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell’ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave».
Le stesse norme invocate dall’INPS, infatti, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost., possono essere lette soltanto nel senso che il limite dei due anni, effettivamente non superabile nell’arco della vita lavorativa (anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori), si riferisca però a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, per scongiurare che alcuno privo resti privo della necessaria assistenza che la legge vuole assicurare.
La ratio dei permessi in narrativa deve esser infatti rinvenuta in un contesto normativo riconducibile ai principi sanciti dall’art. 3, comma 2 Cost., e dall’art. 32 Cost.; i permessi in questione sono diretti non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza: il destinatario della tutela è la persona portatrice di handicap (Corte Cost. n. 19/2009).
La pronuncia in esame si riferisce a fatti antecedenti le modifiche apportate al D.Lgs. 151/2001 e sicuramente potrà rivelarsi preziosa per analogo contenzioso pendente.
Oggi, fortunatamente, non si nutrono più dubbi sul riconoscimento del diritto ai permessi ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 per più di un figlio portatore di handicap: in tal senso, la novella rappresentata dal D.Lgs. 119/2011, che ha introdotto il comma 5-bis nell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, così recita al primo capoverso: «Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap enell’arco della vita lavorativa».
La natura dei permessi
L’ordinanza n. 24206/2020 si occupa di una lavoratrice pubblica che, avendo fruito nell’anno 2006 di un periodo di congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5 citato, per necessità di assistere il figlio minore, ha agito giudizialmente per ottenere, per quel che qui interessa, il riconoscimento delle quote di tredicesima maturate nel medesimo periodo che erano state rifiutate, sul presupposto che l’art. 43, comma 2 del D.Lgs. 151/2001 – pur prima delle modifiche alla disciplina apportate dal D.Lgs. 119/2011 – richiamando le disposizioni di cui all’art. 34, comma 5, escludeva dal computo della mensilità aggiuntiva i periodi di congedo parentale.
Sono interessanti i primi due motivi di ricorso della lavoratrice.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001, nella versione previgente rispetto alle modifiche del D.Lgs. 119/2011, sottolineando come la norma non rinviasse all’art. 34, comma 5, ma alle regole sulla corresponsione dell’indennità di maternità e quindi all’art. 22 (che riconosceva il diritto alla considerazione del periodo di congedo per il calcolo della tredicesima).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la violazione emarginata nel primo motivo, per l’effetto, determini un trattamento discriminatorio, in pregiudizio della situazione di disabilità, oltre che una disparità di trattamento, suscettibile di rilievo sotto il profilo del diritto di eguaglianza, rispetto al caso del congedo (c.d. obbligatorio) per maternità.
La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati.
Incontestato che, ratione temporis, non trovi applicazione il comma 5-quinquies, aggiunto nel 2011 dal D.Lgs. 119 all’art. 42, secondo il quale «il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e deltrattamento di fine rapporto», la Corte di Cassazione condivide le motivazioni della Corte d’Appello, che hanno negato la pretesa attorea: sempre con riferimento alle norme vigenti all’epoca dei fatti, l’art. 43 del D.Lgs. 151/2001, nel regolare il «trattamento economico e normativo» degli istituti di cui al capo V («riposi, permessi e congedi»), mentre dedicava il comma 1 espressamente a riposi e permessi, non poneva delimitazioni quanto alla disciplina di rinvio all’art. 34, comma 5 (contenuta nel comma 2), la quale andava dunque riferita anche ai congedi regolati nell’art. 42, comma 5, in quanto norma facente appunto parte di quello stesso Capo.
Aggiunge la Suprema Corte che la previsione dell’art. 42 comma 5, secondo cui «l’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità» non può riferirsi alla natura degli istituti ma soltanto alle modalità di corresponsione delle indennità.
Peraltro, secondo copiosa giurisprudenza, permessi e riposi riconnessi alle situazioni di disabilità dei congiunti, pur se sottratti in generale alle regole di non computabilità per ferie e tredicesima, quando fruiti autonomamente e in ragione essenzialmente della loro limitata durata, ricadono, invece, nella disciplina di cui all’art. 43, comma 2 e dell’art. 34, comma 5 del D.Lgs. 151/2001, allorquando essi si cumulino con i congedi e contribuiscano a determinare assenze di lunga durata.
Parimenti la Suprema Corte non condivide la prospettazione di una possibile illegittimità costituzionale della previsione, per disparità di trattamento rispetto al caso delle assenze per maternità c.d. obbligatorie, le quali, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.Lgs. 151/2001, non producono effetti riduttivi sulle ferie e la tredicesima.
L’astensione obbligatoria per maternità (o per paternità, al verificarsi delle condizioni di legge) è prevista per la sopravvenienza di un figlio e i corrispondenti diritti vengono fruiti anche se si tratti di figlio disabile, sicché è palese la diversità di condizioni rispetto al caso del congedo parentale per la mera presenza di figli minori o di quello per assistenza ai disabili.
Analogamente non può dirsi fondatamente invocato il verificarsi di una discriminazione.
Quel che rileva, per affermare che vi sia discriminazione, è l’esistenza di un trattamento di sfavore per il discriminato, da misurarsi attraverso una comparazione in astratto rispetto a categorie di persone non interessate dal fattore di protezione che si assume compromesso.
Il termine di paragone, nel caso esaminato, non può essere dato da chi, non avendo necessità dei permessi, lavora ordinariamente; infatti, in tale prospettiva, il genitore del disabile riceve una protezione, potendosi assentare dal lavoro e continuare a ricevere un’indennità pari alla retribuzione mensile; dunque non vi è discriminazione.
Né può essere utilmente invocato il paragone con chi fruisca dei congedi (facoltativi) per altre ragioni parentali diverse dalla disabilità, in quanto il trattamento rispetto a questi casi non è disomogeneo, ma identico e quindi non può esservi discriminazione.
Infine, non può dirsi corretto il raffronto con coloro (mamme, e talora papà) che fruiscono del diritto all’astensione (c.d.obbligatoria) per nascita del figlio e il cui trattamento consente di considerare il periodo di assenza come utile anche ai fini della tredicesima e delle ferie.
Questa circostanza non è infatti paragonabile a quella di chi fruisca del congedo per disabilità del figlio, perché nell’astensione obbligatoria opera la specifica salvaguardia di una diversa situazione, data dalla nascita o adozione di un figlio, la quale peraltro trova applicazione anche quando a sopravvenire sia un figlio disabile, destinatario, come ogni figlio, di tale tutela.
(le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)